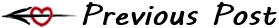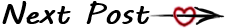E’ strana questa giornata, come se non avesse alcun legame con quelle che l’hanno preceduta e con quelle che la seguiranno.
Una neve gelata e bagnata che cade impietosa sulle primule pallide, sulle gemme di un tenero verde, sui boccioli delicati di mandorli e albicocchi.
Nel cielo plumbeo svolazzano pochi uccelli attoniti e l’aria gelida aggroviglia le cime spoglie delle querce.
Mi sento intorpidita, assonnata, spossata… come un animale destato troppo presto dal suo letargo.
Fino a due giorni fa mi sentivo piena di energie, di pensieri, di idee.
Avevo voglia di fare, di muovermi, di camminare, di scaldarmi al sole, di spalancare le finestre e riempire le stanze di fiori, di chiacchierare e progettare e fantasticare.
Negli ultimi giorni ho pulito tutta la casa da cima a fondo (siamo orfani della colf ormai da tre settimane, ma è meno peggio di quel che avrei creduto), ho decorato il “ramo pasquale“, ho colto e sistemato nei vasi fiori gialli: ranuncoli e canne di fiume, ginestre primaverili, giunchiglie. Ho avuto ospiti le mie amiche quasi ogni pomeriggio, per bere té, mangiare biscotti, chiacchierare, sfogliare riviste.
Oggi invece non ho voglia di fare nulla, non ho voglia di parlare, non ho voglia neppure di muovermi, mi sembra una gran fatica perfino camminare da una stanza all’altra!
Potrei fare decine di cose, ma non ne farò neppure una.
Oggi non mi sento triste, ma stanca… come svuotata da quest’ultimo colpo di coda dell’inverno.
Sono di umore riflessivo ma non costruttivo: riflessioni oziose e svogliate, indolenti ed inerti.
Vincendo l’accidia che mi intorpidisce le membra mi preparo un tè: Neige de Soie di Mariage Frères.
Verso l’acqua in una tazza color ciliegia di Coté Table, 7 minuti di infusione, mi munisco di un tovagliolino rosso e di un sotto-tazza di giunco intrecciato, bordato di piccole conchiglie tropicali (l’ho comprato alcuni anni fa sull’isola di Mahe, alle Seychelles, in un emporio di artigianato creolo). Chissà che il sapore erbaceo del tè, il rosso e il ricordo di una spiaggia bianca non stemperino il grigio di questo pomeriggio uggioso?
Il libro più adatto ad una giornata come questa è “Madame Bovary” di Gustave Flaubert.
E’ uno dei romanzi che preferisco, uno di quei libri essenziali di cui l’umanità non potrebbe più fare a meno.
E’ il manifesto di un certo modo di vivere e di sentire: di un impotente, continuo e vano anelito di spiriti (forse) mediocri verso l’alto; di un tumulto di desideri repressi ed ambizioni stroncate; di un insopprimibile fastidio del quotidiano accompagnato da una lacerante nostalgia dell’impossibile.
E’ la cronaca del dolore del prigioniero che, in mezzo alla sua allucinazione di libertà, urta con il capo contro il soffitto basso della cella.
E’ il mitico e crudo contrasto tra realtà e sogno, tra spleen et idéal.
Ma come si fa a non amare Emma Bovary? Come si fa a non indulgere in comprensione per le sue torbide fantasie e per i suoi ardimenti folli?
Come si fa a non discolpare il suo fallimentare tentativo di vivere, a suo modo, in poesia?
Lei che ha aborrito la tovaglia di tela cerata, che ha respinto il solo uomo che l’avesse (un poco e banalmente) amata, che ha dimenticato perfino d’essere madre per inseguire i fuochi fatui della sua immaginazione e che infine ha dovuto soccombere al poco poetico ed impietoso destino dei delusi dal mondo, che non chiedevano altro che la felicità!
Felicità forse futile, forse apparente, forse meschina perché gravemente e grevemente materiale… ma non ha forse diritto ognuno di inseguire la sua propria felicità, senza giudizi e moralismi altrui?
Sarà anche stata patetica la povera Emma, forse il tutto a cui tendeva spasimando, altro non era che niente… ma io l’ho amata e mi sono spesso sentita simile a lei.
Ed è per questo che la discolpo e la giustifico, che mi irrito per il modo in cui a tratti Flaubert la dipinge, ridicolizzando le sue tendenze romantiche (come se bisognasse per forza guardarla con moralistica riprovazione), e che mi piace più di ogni altra la definizione che ha dato di lei Baudelaire di creatura “sublime nel suo genere”.
“Emma portava una vestaglia tutta aperta che lasciava scorgere, tra i risvolti a scialle del corpetto, una camicia pieghettata con tre bottoni d’oro.
La cintura era un cordone terminato da grosse ghiande; le pantofoline di color granato avevano un nodo di larghi nastri, che andava a posare sul collo del piede.
S’era acquistata una cartella, una scatola di carta da lettere, un portapenna e delle buste, benché non sapesse a chi scrivere; spolverava la mensola, si guardava allo specchio, prendeva un libro e poi, fantasticando tra le righe, se lo lasciava cadere sulle ginocchia.
Aveva voglia di fare dei viaggi o di tornare a vivere nel suo convento.
Desiderava di morire, e al tempo stesso di vivere a Parigi”.